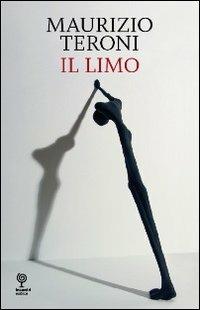Alessandro Baldacci (Padova, 1970) insegna Letteratura italiana contemporanea presso l’Università di Varsavia. È fra i curatori dell’antologia Parola plurale (2005). Ha pubblicato due monografie su Amelia Rosselli (2006) e i volumi Andrea Zanzotto. La passione della poesia (2010); Controparole. Appunti per un’etica della letteratura (2010); Le vertigini dell’io. Ipotesi su Beckett, Bachmann e Manganelli (2011); La necessità del tragico (2014); Giorgio Caproni. Un’inquietudine in versi (2016), Le voragini del lirico. Milo De Angelis (2020). Nel 2023, per la casa editrice PeQuod ha pubblicato il suo primo libro in versi dal titolo Il dio di Norimberga.
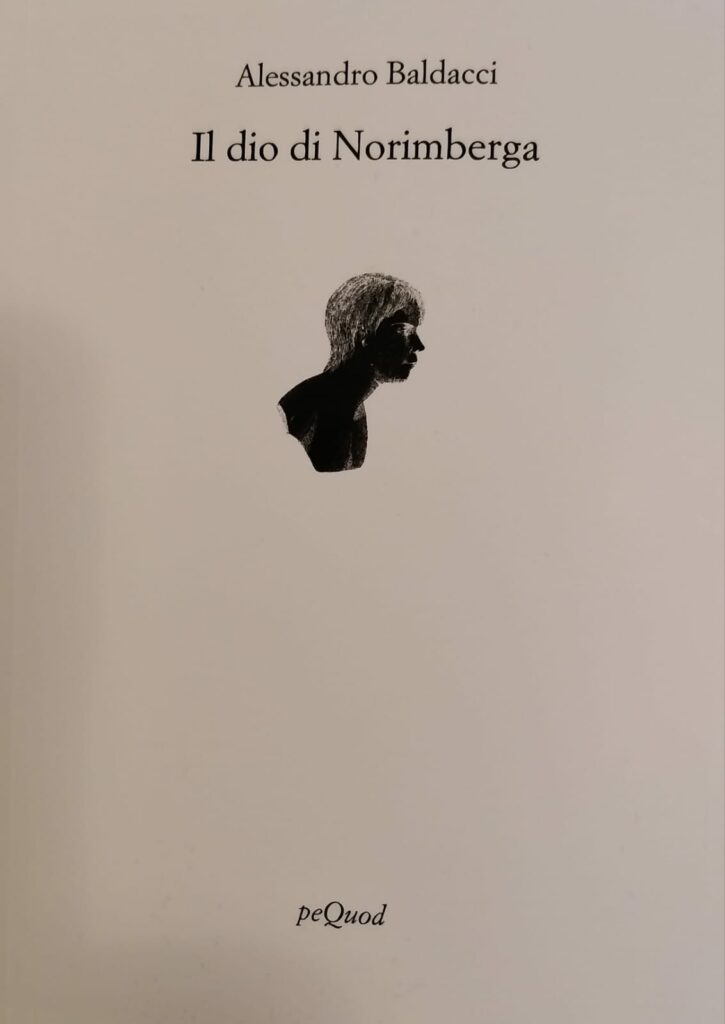
Teroni
Buongiorno Baldacci. Il tuo libro, Il dio di Norimberga, è un poema narrativo nel quale, a livello di contenuti, si mescolano vari elementi. Voglio adesso soffermarmi al piano formale. Il testo è scritto in versi, mi pare tutti o decasillabi o settenari, divisi in ottave. Non vi sono rime regolari, ma sicuramente moltissime assonanze. Insomma, segue una impostazione metrica piuttosto precisa. La mia semplice prima domanda è: perché hai fatto una scelta di questo tipo?
Baldacci
Buongiorno, e grazie per questa domanda che mi permette di riflettere su una questione che considero nevralgica. Direi che lo scrivere in versi mi appare impossibile al di fuori di una forma che faccia da morsa. Si tratta della ricerca di un orizzonte stretto in cui seguire i propri demoni significa riconoscere il loro ruolo, in primo luogo, di “legislatori” e “costruttori”. Per questo scrivendo e riscrivendo più volte il libro sentivo sempre più netta l’esigenza di incatenare tutti gli elementi portanti disordine in una forma funzionale alla compressione e all’addensamento. A posteriori direi che ho provato a lavorare sull’ottava trattandola come una sestina, puntando in questo modo anche a contestare, se possibile, dal di dentro, alcuni elementi che considero posticci della narrazione e del narrare lineare, spingendo e forzando il pedale della combinazione, trasformando il rapporto fra tema e variazione, fra testo e sequenza, fra limiti del linguaggio e poema, nel vero filo (e fuoco) del discorso. C’era poi il desiderio di dare forma, metricamente, a un cantabile straniato, a una filastrocca-farsa, a una trottola di immagini, straniamenti e suoni.
Quindi, fammi capire meglio, una forma così rigida, è una strategia per obbligare o invitare il lettore ad approcciarsi in modo più impegnativo al testo, e quindi chiedere, implicitamente, maggior concentrazione?
Non per chiedere più concentrazione al lettore ma piuttosto per imporla all’atto stesso della scrittura. La figura del lettore per converso può legittimamente trovare in questa chiusura un senso di soffocazione e disagio, ma, per rifarmi ad Antonio Porta, penso che fra le funzioni principali dell’arte ci sia anche quella di “seminare asfissia”. La forma dunque per me vale tanto come gabbia, imprigionamento, catena, che come molla creativa; il suo compito infine è quello di trasformare il vincolo, l’artificio, in una seconda pelle, in una scelta di stile che deve marchiare l’immaginario e la pagina.
Già che parliamo di “lettore”, ti chiedo: esiste secondo te un lettore ideale? E quanto, secondo te, l’interpretazione, e quindi lo spazio creativo di un’opera, è in mano al lettore?
Credo e confido molto nel “genio” del lettore e nella sua capacità di porre domande radicali al testo, di dare vita, a volte, persino a misletture dall’altissimo, potenziale, profitto creativo. Quella della lettura è per questo un’esperienza fondamentale quanto quella della scrittura, e proprio in quanto esperienza non può lasciare immutato né il lettore, né l’autore, né il testo stesso. Si tratta di collegare etica e arbitrio, ascolto e immaginazione, integrità e alterità, tensioni e proliferazioni di senso (e/o non-senso). Per questo a mio avviso il lettore ideale non è chiamato a ricalcare passivamente il testo, non si esaurisce nell’approssimarsi (criticamente e/o esistenzialmente) alle intenzioni dell’autore, ma deve entrare in dialogo frontale con esse, riaccentuarle in forza del proprio orizzonte di vita. Agendo in ciò che legge il lettore offre al testo prospettive e “intenzioni” spesso inedite, non preventivate, ma indispensabili per la vita dell’opera. Proprio per questo nello scrivere considero osceno ogni ammiccamento al lettore, ogni rincorsa volta ad accattivarselo, ogni strategia intenzionale che per coinvolgerlo sia disposta a eliminare ostacoli (a volte insuperabili) o distanze (che devono, per converso, essere sperimentate), puntando a una falsa cordialità, a un discorso “addomesticato”, incapace di accendere la necessità della domanda.
Nel tuo libro Il dio di Norimberga vi è un netto invito al lettore a collaborare sul piano interpretativo. Perché è come se ponessi un enigma: “di cosa parla questo libro?” Mi sono chiesto leggendolo. La prima risposta che mi viene è “della seconda guerra mondiale”. Ma la risposta è lì ma non lì. Non ti chiedo di darmi la chiave. Ti chiedo però se tu hai una chiave o se tu stesso hai cercato una chiave, scrivendolo.
Nello scrivere mi ha guidato un’idea di infanzia intesa come epifania dell’alieno, dell’inerme e del selvaggio, come sentiero di fuga che rifiuta di seguire i binari della storia (sappiamo dove quei binari hanno portato e dove continuino a portare). Si tratta della sperimentazione di una fantasia che prova ad accostarsi al trauma e alla paura di un bambino chiuso in se stesso, “improtetto”, sospeso fra solipsismo e immersione nelle ferite della cronaca, a tratti divinamente indifferente e quasi immune dal dolore che il mondo gli procura, più spesso spugna costretta a subire (e ad assorbire) la violenza di “pedagogie nere”, da regime, in cui tocchiamo le radici di una cultura fondata sulla sottomissione dell’altro, molto più prossima alla barbarie e al fascismo che alle ragioni di una pedagogia etica. Il libro in questa ottica nasce e ruota attorno a una rilettura decisamente arbitraria e allucinata della sorte di due “ragazzi selvaggi”, Kaspar Hauser e Victor dell’Aveyron, “chiamati” a funzionare come pedine impazzite, figli e doppi di Dioniso, che nella loro “alterazione” (intesa come “dono” che ci offre chi ha sete sfrenata di giustizia) provano a sbracciarsi, mente vengono travolti dall’onda (e dall’orda) della storia, e proprio in forza del loro istintivo, continuo dimenarsi portano avanti la richiesta ossessiva di un anticipo (utopico? vendicativo?) di giudizio universale. Il rimando alla seconda guerra mondiale, a cui hai fatto giustamente riferimento, mi sembra agire nel libro in veste di spettro che si affaccia verso un presente in cui, di giorno in giorno, si fa sempre più allarmante l’incubo autodistruttivo di un terzo conflitto planetario.
Vorrei ora porti una domanda di tipo tecnico pratico: come organizzi la tua scrittura? Ti prepari uno schema a cui ti attieni oppure segui una scia istintuale, diciamo così, cieca? E quanto del tuo lavoro è dato dalla rifinitura, dalla revisione, e quanto invece è lasciato alla parte immediatamente creativa?
Scrivo sentendo come non distinguibili l’irruzione di qualcosa che vuole essere gettato sul foglio e l’esigenza di calcolo, di gabbie, di manipolazione (legata a un fare ludico-infantile e tecnico-artigianale al contempo). Cerco di impastare l’immaginario, di lavorarlo come un materiale potente quanto radioattivo, di disporlo sulla pagina per dargli più densità, spessore, peso. Ciò che ne risulta deve poi entrare in rapporto con le sequenze (e il libro) in cui il testo è inserito. Il passo successivo, dopo mesi, consiste nel mettere alla prova singoli componenti e sequenze, vedendo se altre modalità di combinazione o intrusione di fatti e parole si conferma, come quasi sempre accade, indispensabile. Le varie riscritture finiscono così per rivoluzionare e rideterminare quasi integralmente il corpo finale del testo e il dialogo fra i testi. Ogni componimento viene rielaborato e ricombinato sino a una sorta di saturazione massima, tale da non lasciare spiragli o pieghe per alte operazioni. A volte però capita che una nuova parola o immagine si imponga improvvisamente e perentoriamente: a quel punto devo disseminarla ovunque, scombinare e ripensare per intero il libro, disfare e rimontare i pezzi sino a che non assumono una loro versione/variazione capace in qualche di chiudere sino a un certo punto il cerchio.
Per concludere, il gioco della torre. Sei costretto a mettere in valigia uno di questi due libri: Allegria di naufragi di Ungaretti o Ossi di seppia di Montale. Quale scegli e perché?
Sicuramente sceglierei gli Ossi di seppia di Montale. Soprattutto nell’edizione del 1928. Riconosco ovviamente la grandezza di un libro come Allegria di naufragi ma devo aggiungere che, per certi versi, il vitalismo ungarettiano, anche se autentico e drammatico, chiaramente anti-dannunziano e anti-retorico, dall’indiscutibile significato storico, esistenziale, “biologico”, riesce a parlarmi meno rispetto all’opera di esordio di Montale. Preferisco infatti il diverso naufragio, nella rete a strascico della storia, che incarna la parola e la parabola di Montale, il suo “I prefer not to”, gli accordi della sua sterile angoscia da uccello in gabbia, la sua cocciuta perplessità di fronte a una vita che vede, già nel quotidiano, oscillare fra crudeltà e nonsenso. Spesso negli Ossi di seppia il pensiero sembra prendere la forma di un dire che incontra subito una condizione esausta, una macerazione che si fa destino, piena di acuti ultimativi, come quando leggiamo: “la mia venuta era testimonianza / di un ordine che in viaggio mi scordai” o ancora: “Bene lo so: bruciare, / questo, non altro, è il mio significato”. Versi come questi comunicano il senso di un lucido capogiro, di radice tragica, in grado di ridurre a scoria (o autocombustione) la passione e l’anima romantica: prossimi piuttosto, a una rielaborazione modernista dell’hölderliniano “Ein Zeichen sind wir, deutungslos” (“Un segno siamo, senza significato”). La poesia “Arsenio” infine, è un testo che amo molto, a partire dalla creazione di un alter-ego che permette all’io, apparentemente fuori dal testo, di giungere a toccare sino in fondo il suo vuoto sulla pagina, un vuoto reale, estraneo alla “magia” simbolista, dove il banale si fa epifanico in quanto accelera il montare dell’incubo, del negativo. Tutto ciò dentro una poesia dove l’andamento narrativo pare nato per implodere, per fallire, per sbattere contro il reale, cosciente dell’abisso che abbiamo sotto i nostri piedi.
(dalla sezione “Sasha”)
I
Segui a Padova la strada
o la baccante che strappa
le vesti a Sasha e le lascia
in piazza, mentre le mosche
dormono ancora nel latte
oppure sotto la sabbia,
dove la mano di Kaspar
colora tutto di rosso.
II
Sasha ora rientra nel bosco
gridando: «Padova o morte»,
mentre le mani di tutti
restano dietro la porta,
e lui rincorre la palla
vicino all’ombra di Kaspar,
fino a che gli ufo e le mosche
fanno girare la testa.
III
Assassinano il grano nell’alba
gli occhi chiusi che vedono rosso,
mentre Padova è un pezzo di carta,
una via di baccanti nel parco,
fino a quando rimbalza la palla
e le nonne gli gridano in testa:
«porteremo di nuovo baccanti
nella piazza a giocare con Kaspar».
(da Il dio di Norimberga, 2023 PeQuod)